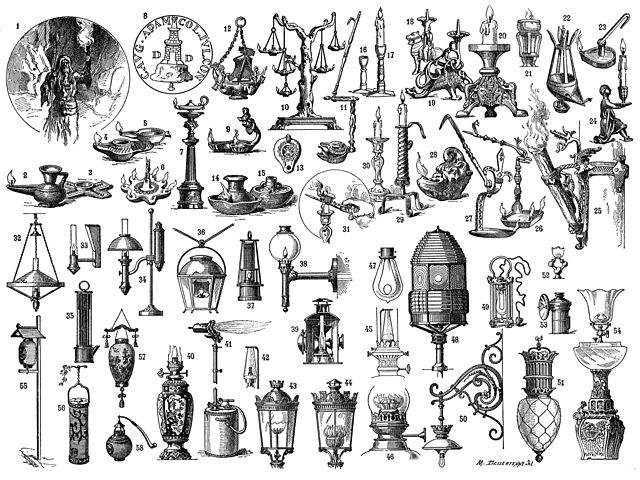Nel 1914, nel Comune di San Giorgio di Piano, si passava dall’illuminazione pubblica a gas acetilene all’illuminazione elettrica. Ma come avvenne questo passaggio?
Nel lontano 1912, la Società elettrica di Bologna chiese di iniziare le pratiche per impiantare una rete di pubblica illuminazione elettrica a San Giorgio. La Giunta, allora presieduta dal Sindaco Gaetano Rossi, pensando che questo nuovo sistema fosse più sicuro, economico e pratico rispetto al sistema sino a quel momento utilizzato, affidò all’assessore Gaetano Tommasini l’incarico di studiare l’argomento.
L’impianto ad acetilene e le analisi sui costi
San Giorgio attraversava, in quegli anni, uno “sviluppo dell’arte edilizia”, con un aumento delle dimensioni del paese che aveva reso l’impianto d’illuminazione a gas acetilene insufficiente, ed era quindi indispensabile la sua estensione, oppure la sua sostituzione con un impianto a luce elettrica. Le due soluzioni vennero vagliate dall’Amministrazione pubblica, con l’intento di conciliare funzionalità e “maggior utile per le finanze del Comune”. In un primo momento, si prese in considerazione la possibilità di conservare l’impianto esistente, in quanto aveva dato durante gli anni un ottimo risultato, ma in seguito l’analisi di alcuni dati oggettivi fece decidere diversamente.
La Società centrale d’elettricità, infatti, aveva già collegato alla rete elettrica il Comune di San Giorgio di Piano: dal settembre 1911 aveva avuto il nulla osta per “impiantare nel nostro Comune una linea elettrica per il trasporto e diffusione dell’energia a scopo industriale domestico ed agricolo”. Ciò aveva indotto a ricorrere a questo tipo di energia sia gran parte degli industriali per i propri “opifici” che molti privati per le utenze domestiche. Pertanto, rimanevano “ben pochi utenti” che utilizzavano ancora il gas acetilene, e in queste condizioni l’azienda che gestiva quell’impianto si trovò nella necessità di chiedere un aumento delle prezzo del gas acetilene per fiamma-ora (da 5 a 6 centesimi l’ora), provocando così un notevole aumento nel costo dell’illuminazione. Gli amministratori valutarono anche la possibilità di una gestione comunale di questo servizio, ma anche in questo caso un’analisi dei costi, tra l’acquisto del carburo, la retribuzione del personale e le spese per la sostituzione del materiale deteriorato, rivelò che non si sarebbe avuta una diminuzione dell’onere economico. Il preventivo era di circa £ 3.000, pari a quello che la ditta appaltatrice già richiedeva.
Fu contattata quindi la società anonima “Gas-Elettricità” della ditta Chiari, concessionaria della centrale per questa zona, e in base al numero di lampade che si volevano istallare e alla loro potenza, questa richiese un canone di £ 2.500. Confrontando tale spesa con quella precedente, la Giunta non ebbe più alcun dubbio, tanto più che l’intensità luminosa sarebbe aumentata notevolmente.
L’affidamento del servizio di illuminazione elettrica
Fu quindi disdettata la gestione della ditta Olivari di Milano, che conduceva dal 1905 l’impianto pubblico d’illuminazione a gas acetilene, e il servizio fu dato in concessione alla società elettrica per 10 anni. L’accordo prevedeva che nella cifra calcolata fossero ricomprese tutte le spese d’impianto, la somministrazione di materiali, la fornitura della corrente elettrica, il personale di sorveglianza, la manutenzione, il ricambio delle lampade a incandescenza e quant’altro potesse occorrere. Il contratto con la società elettrica avrebbe dovuto iniziare già nel gennaio del 1914, ma la lentezza delle pratiche comportò lo slittamento di alcuni mesi, durante i quali il Comune assunse provvisoriamente il servizio d’illuminazione a gas acetilene, al fine di mantenere funzionante il servizio pubblico.
L’Amministrazione comunale, inoltre, aiutò la società elettrica nel richiedere ad alcuni proprietari di case il permesso di applicare nel loro edificio un gancio, per fissare i fili che dovevano sostenere le lampade poste nel mezzo della strada, assicurando che tutto sarebbe stato fatto in modo da non deturpare gli edifici. Analoga richiesta fu fatta anche alla Sopraintendenza ai Monumenti dell’Emilia-Romagna, la quale diede il consenso per l’affissione di un piccolo gancio sulla fronte Sud-Ovest della porta ferrarese, e un altro nella parete Nord-Ovest del Torresotto, allora proprietà della famiglia Caliceti, purché non si danneggiassero i due edifici monumentali.
Dislocazione e dettagli sui punti luminosi
I punti luce di diversa potenza che iniziarono a funzionare nel 1914 furono 33: erano lampade sospese, a braccio, a fune o a mensola, ed erano provviste di un riflettore. Il loro posizionamento ci permette di capire meglio quali fossero in quel tempo le dimensioni di San Giorgio.
|
9 lampade |
Lungo la strada Umberto I° (l’attuale via Libertà), a una distanza di circa m. 35 l’una dall’altra |
|
4 lampade |
Nel tratto che va dalla Piazza Indipendenza al termine del viale XX Settembre |
|
6 lampade |
Nella via Ivo Pradelli (e via della Pace), già via Merlina |
|
1 lampada |
Nel Borgo San Rocco |
|
3 lampade |
Nella via Torresotto (ora via G. Rossi) e Fortitudo (gruppo sportivo) |
|
2 lampade |
Nella via Circonvallazione e precisamente nel crocevia fra detta strada e via Vittorio Emanuele II, e un’altra presso il fabbricato comunale delle stalle (alle estremità di via 2 Giugno) |
|
2 lampade |
In via Francesco Ramponi |
|
2 lampade |
Nel viale a Nord del paese |
|
1 lampada |
Nel viale della stazione |
|
2 lampade |
Nelle latrine pubbliche |
|
1 lampada |
Sulla parte della Chiesa prospiciente il Campanile |
Alcuni mesi dopo, si sentì la necessità di aggiungere un altro punto luminoso sulla via di Circonvallazione, nel lato Nord di porta Ferrara.
Il contratto con l’azienda elettrica prevedeva che le lampade fossero a filamento metallico, con l’impegno però a sostituirle con altre, qualora la tecnologia avesse scoperto un sistema migliore. Secondo lo stesso contratto, le lampade dovevano essere sostituite quando la loro intensità luminosa fosse diminuita, a causa dell’usura, del 15%, e in ogni caso dopo 1000 ore di accensione. La concessione dettagliava anche gli orari d’accensione, a seconda dei periodi dell’anno.
La tabella che segue ne riporta dettagliatamente gli orari.
|
mesi |
dal 1° |
al 10 |
dal 11 |
al 20 |
dal 21 |
alla fine |
|
accensio. |
spegnim. |
accensio. |
spegnim. |
accensio. |
spegnim. |
|
|
ore |
ore |
ore |
ore |
ore |
ore |
|
|
Gennaio |
17,15 |
7 |
17,45 |
7 |
17,45 |
17 |
|
Febbraio |
18 |
6,30 |
18,15 |
6,30 |
18,30 |
6,15 |
|
Marzo |
18,45 |
6 |
19 |
5,45 |
19,15 |
5,30 |
|
Aprile |
19,30 |
5 |
19,30 |
4,45 |
19,45 |
4,15 |
|
Maggio |
20 |
4 |
20,15 |
3,45 |
20,30 |
3,15 |
|
Giugno |
20,30 |
3,15 |
20,30 |
3,15 |
20,45 |
3,15 |
|
Luglio |
20,45 |
3,15 |
20,45 |
3,15 |
20,30 |
3,30 |
|
Agosto |
20,30 |
3,30 |
20 |
4,15 |
19,30 |
4,30 |
|
Settembre |
19,30 |
4,30 |
19 |
5 |
18,45 |
5,15 |
|
Ottobre |
18,30 |
5,30 |
18,15 |
5,45 |
18 |
6 |
|
Novembre |
17,45 |
6,15 |
17,30 |
6,15 |
17,15 |
6,15 |
|
Dicembre |
17,15 |
7 |
17,15 |
7 |
17,15 |
7 |
Il concessionario era tenuto a rispettare gli orari e sanzioni erano previste in caso di ritardi o mancate accensioni; un’eventuale rottura dei filamenti delle lampade o delle valvole di sicurezza era tollerata solo se pari o inferiore al 5%.
Gli agenti municipali avevano l’obbligo di sorvegliare l’impianto elettrico “come se fosse del Comune”, elevando anche contravvenzioni a chiunque avesse danneggiato le condotte elettriche, le lampade, gli appoggi, eccetera. Tariffe speciali erano state previste per tutti gli edifici comunali: l’energia fornita per la loro illuminazione era scontata del 20% rispetto al prezzo praticato ai privati.
Recupero del vecchio impianto e utilizzo nei primi tempi
Una clausola del contratto, richiesta dal Consigliere Avv. Eraldo Gaiani, prevedeva che i fanali precedentemente esistenti (a gas acetilene) fossero conservati in locali del Comune, per essere utilizzati nell’eventualità che forze maggiori (“bufere, uragani, inondazioni, guerra guerreggiata, scariche atmosferiche, attentati insidiosi”) avessero reso inservibile l’impianto elettrico.
L’impianto sostituito trovò effettivamente un nuovo impiego già alcuni mesi dopo, nel 1915, quando venne istallato nelle tre frazioni, affidando l’incarico di accensione e spegnimento a personale locale. I fanali erano così posizionati: 4 a Gherghenzano, 2 a Stiatico e 3 a Cinquanta. Nelle frazioni, l’illuminazione elettrica pubblica arrivò alcuni anni dopo: nel 1928 a Cinquanta e Gherghenzano e nel 1930 a Stiatico.
Un’unica annotazione nei verbali della Giunta comunale ci racconta come l’illuminazione pubblica incontrò inizialmente alcune difficoltà. Un andamento poco regolare del servizio da parte della ditta appaltatrice fece riflettere se fosse il caso di municipalizzare e gestire direttamente il servizio stesso, ma nei mesi e negli anni successivi non si trova più traccia di tali problematiche, se non la necessità di un’illuminazione maggiore.
Lo scoppio della Prima guerra mondiale richiese la modificazione del servizio: il 19 ottobre 1916 fu infatti emanato un decreto luogotenenziale, nel quale si disponeva che l’illuminazione pubblica in tutti i Comuni si dovesse ridurre della metà dall’ora dell’accensione alle 22,30 e di un quarto da quell’ora sino al momento dello spegnimento. Il nostro impianto, però, non poteva essere ridotto automaticamente ogni sera dalle 22,30 al minimo consentito, per cui l’Amministrazione comunale decise di ridurre la potenza luminosa a un quarto, passando da 2325 a 575 candele.
Nel successivo mese di dicembre, per ulteriori diposizioni, si invitò la società appaltatrice dell’illuminazione pubblica a oscurare le lampade con tinteggiatura azzurra, mentre si sospese l’illuminazione a gas acetilene nelle frazioni. La riduzione di un quarto e la tinteggiatura azzurra delle lampadine “rendeva il castello privo affatto di luce” per cui l’Amministrazione, il 9 agosto 1918, stabilì che per ragioni di sicurezza era più opportuno limitare la riduzione alla sola metà della potenza.
L’illuminazione a metà dell’Ottocento
Facendo un salto in avanti di oltre cento anni, possiamo confrontare i 33 punti luce di allora, limitati al capoluogo, con gli attuali 1717, su tutto il territorio comunale.
Ma tornando ancora più indietro, alla metà dell’Ottocento, vedremmo che intorno al 1850 e sino al dicembre del 1858 in paese esisteva un unico punto luminoso, finché la Brigata Gendarmi chiese diattivare “ in questo Castello almeno 2 fanali notturni nella strada principale non essendo bastante il solo fanale ora esistente”. Un’analoga richiesta era già stata avanzata nel 1852, ma i carichi economici del Comune suggerirono di rimandare la spesa a momenti migliori.
Nel 1858, superate le difficoltà economiche, il Priore Vincenzo Baccilieri (il “Sindaco” di allora) propose alla Magistratura (l’attuale Consiglio comunale) l’aumento di due fanali, da collocarsi nei punti più importanti della strada principale. Il Consiglio della Comunità di Castel San Giorgio approvò la proposta, ritenendo “che quanta maggiore luce si può dare di notte alle strade, tanto meglio si toglie l’occasione ai malviventi di sottrarsi alla forza pubblica [….] è dovere del Magistrato di provvedere con tutti i modi che sono in suo potere alla sicurezza degli abitanti”.
Nel giugno del 1863, la realizzazione della linea ferroviaria Bologna-Ferrara e della stazione – oltre alla costruzione della nuova piazza e della strada che metteva in comunicazione il paese con la stazione e la via di Bentivoglio – resero necessario l’inserimento di un nuovo fanale. L’appaltatore dell’illuminazione notturna, il Sig. Giovanni Trebbi, doveva accendere questo fanale per 2 ore circa, un’ora prima e un’ora dopo l’arrivo del treno da Ferrara, ma “ solamente nelle sere in cui non splendeva chiara la luna”.